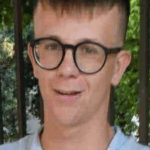Il nome arriva da un paese minuscolo eppure fermo al centro di una storia lunga secoli: Felino. Il salame che porta la sua etichetta non è un’etichetta qualunque. È un taglio di territorio, sapienza e mestiere, messo nero su bianco da un disciplinare che lo tutela. Ma che cos’è, davvero, il Salame Felino IGP? E perché, negli ultimi anni, i suoi dati economici cominciano a farsi notare?
Leggi anche: Coppa di Parma IGP, il carattere discreto di un’eccellenza di territorio
Origini e territorio: Felino non è uno slogan
Il “Felino” non è un vezzo da marketing, ma una radice geografica precisa. La produzione del Salame Felino IGP è riconosciuta nell’intera provincia di Parma, un’area dove clima, aria e tradizione favoriscono la stagionatura e la conservazione degli insaccati. Le prime tracce scritte che legano il salame a Parma risalgono al Quattrocento: è un prodotto che ha saputo trasformare la disponibilità di materie prime e il paesaggio in una identità.
Il disciplinare: poche regole, molta differenza
Il Salame Felino IGP prende la sua personalità da regole semplici ma rigorose. Si stabilisce quali parti del maiale possono essere impiegate, i parametri di macinatura, l’uso di sale, pepe e, se si vuole, di un tocco di vino bianco secco. Sono dettagli tecnici che fanno la differenza, perché garantiscono riconoscibilità e continuità. Non è un rito da osservare per tradizione, ma la chiave che tiene insieme memoria e futuro.
Passo dopo passo: come nasce il Salame Felino
Dalla scelta delle carni non congelate fino alla stagionatura, ogni fase è un equilibrio tra artigianato e controllo. La macinatura deve avere grana precisa, l’impasto viene insaporito con le dosi stabilite di sale, pepe e aglio, poi insaccato in budello naturale e legato a mano. Seguono alcuni giorni di asciugatura e almeno venticinque di stagionatura, in ambienti con temperatura e ricambio d’aria controllati. È in queste stanze che il tempo lavora insieme ai produttori, regalando aromi e muffe naturali che fanno parte della sua identità.
Il taglio e il gusto: come riconoscerlo
La consistenza è compatta, non elastica. Al taglio la fetta si presenta rosso rubino, punteggiata da grani di pepe. Il profumo è delicato, il sapore dolce ed equilibrato. La tradizione consiglia di affettarlo in modo leggermente obliquo, a becco di clarino, per restituire la giusta armonia tra carne e spezie. Basta uno spessore di mezzo centimetro per coglierne appieno la ricchezza.
Museo e memoria: il salame che si racconta
Non è soltanto produzione, ma anche cultura. A Felino esiste un museo dedicato al salame che dal 2024 ha una nuova sede in via Carducci. Qui si incontrano strumenti antichi, testimonianze e perfino un ago di bronzo romano: tracce che raccontano quanto lunga e stratificata sia la storia di questo prodotto. Visitare il museo significa capire che dietro una fetta ci sono persone, paesaggi, gesti ripetuti per generazioni.
I numeri che valgono: produzione e mercato
Il 2024 ha confermato la vitalità del Salame Felino IGP. Il fatturato al consumo ha superato gli 89 milioni di euro. Parliamo di una crescita rispetto all’anno precedente, mentre il valore della produzione ha toccato i 46 milioni. Sono stati lavorati più di cinque milioni di chili di carne, con tre milioni e mezzo trasformati in prodotto certificato. Interessante anche il dato sul preaffettato, che resta superiore ai livelli pre-pandemia, e quello sull’export, ancora minoritario ma in forte crescita, soprattutto verso Germania, Francia e Svizzera. A inizio 2025 il Consorzio ha aggiornato il disciplinare, introducendo tra le altre cose un nuovo riferimento al peso delle carcasse, così da armonizzare le regole con quelle europee. Un dettaglio tecnico che testimonia l’attenzione costante alla qualità e all’evoluzione del settore.
In cucina: poche regole ma buone idee
Il Salame Felino IGP trova la sua casa nell’antipasto alla parmense, accanto alla torta fritta o alle micche di pane. Va gustato subito dopo il taglio, perché l’aria ne altera rapidamente la freschezza. Si abbina con vini morbidi e aromatici della zona, come la Malvasia dei Colli di Parma. Una curiosità: appena tolta la pelle, la fetta sprigiona profumi più intensi, segno che la sua forza è tutta naturale.

Sono giornalista pubblicista laureata in letteratura e content manager con una grande passione per la scrittura